L’uomo dai denti tutti uguali
Philip K. Dick
di Iannozzi Giuseppe
 Gli anni Cinquanta in America, come del resto in tutto il mondo, presentavano una società che respirava ancora l’aria avvelenata che il nazismo hitleriano aveva corrotto: l’idea borghese che veniva propagandata era quella di un profondo bigottismo di convenienza, le classi sociali erano ancora divise, ci si guardava con sospetto quasi che il proprio vicino di casa potesse essere una spia di una qualche società segreta governativa o paragovernativa, e la pubblicità invitava la società al più becero consumismo; insomma la collettività non aveva miti a cui guardare se non a quelli del passato, nulla affatto esemplari.
Gli anni Cinquanta in America, come del resto in tutto il mondo, presentavano una società che respirava ancora l’aria avvelenata che il nazismo hitleriano aveva corrotto: l’idea borghese che veniva propagandata era quella di un profondo bigottismo di convenienza, le classi sociali erano ancora divise, ci si guardava con sospetto quasi che il proprio vicino di casa potesse essere una spia di una qualche società segreta governativa o paragovernativa, e la pubblicità invitava la società al più becero consumismo; insomma la collettività non aveva miti a cui guardare se non a quelli del passato, nulla affatto esemplari.
La guerra fredda fra USA e URSS continuava la sua rapida ascesa: non passava giorno che non se ne parlasse con voce sussurrata, perché parlare di certi argomenti a voce alta era ritenuta cosa rischiosa quanto di cattivo gusto. La grande epoca del jazz e del blues degli anni ’30 e ’40 stava lasciando ormai il posto al rock: personaggi come Charlie Parker, Louis Armstrong, Duke Ellington, Benny Goodman lasciavano la scena della ribalta per farsi sostituire dai più moderni Platters. E poi venne anche Elvis The Pelvis, prima icona erotica di una America sempre più votata al culto dell’immagine: Elvis rappresentò, allo stesso tempo, lo scandalo ma anche il costume virile della società borghese, e proprio per questa sua presunta virilità l’America fu pronta a perdonare i suoi eccessi. Elvis proponeva al mondo l’immagine di una società virile per nulla piagata dalla Seconda Guerra Mondiale.
Intanto nelle strade gli alcolizzati e i drogati continuavano a crescere di numero per spegnersi subito in un conato di vomito: basti ricordare il mito dell’uomo on the road proposto da Jack Kerouac, o quello più mistico e arrabbiato di Allen Ginsberg, che ebbero voce in capitolo negli anni Cinquanta più per l’immagine che gli era stata cucita addosso che non per i contenuti da essi proposti. I grandi scrittori, gli artisti in genere, vivevano un momento di confusione: Henry Miller non scandalizzava più con le sue storie di sesso estremo; l’America aveva imparato a vivere le sue pulsioni sessuali nell’anonimato e guai a chi intendeva sbandierare il proprio costume sessuale ai quattro venti; la regola era che tutto era ammesso purché restasse nella buia intimità della propria prigione di carne. Il fatto che Miller parlasse di sesso senza mezzi termini serviva alla società per appagare le sue curiosità: un siffatto stato di cose non poteva che star bene all’America puritana, perché Miller era stato ormai bandito dal buon costume, ma serviva, suo malgrado, la causa dell’oscurantismo (a sua insaputa, Henry Miller favorì l’oscurantismo negli anni ’50…), difatti se il volgo voleva conoscere le sue perversioni aveva a disposizione un prete nella figura di H. Miller pronto ad ascoltare per poi scriverne. Sarebbe stato impossibile senza H. Miller per l’America puritana avere una società di individui dai “denti tutti uguali”, il solito sorriso stereotipato espressione di un fittizio benessere sociale. Miller serviva alla società per fugare il sospetto dall’opinione pubblica che l’America nascondesse perversioni ben più peggiori della sua sessualità repressa.
1984 di George Orwell era un romanzo proibito, di quelli veramente da mettere all’Indice perché svelava le trame oscure del Potere e l’immondizia che in esso covava; e il Potere americano era la pubblicità, l’invito a uno spietato consumismo, quella pubblicità che era ed è ancor oggi la base per una politica falsa promotrice di un fittizio diritto all’eguaglianza fra le classi sociali.
Philip K. Dick avvertiva tutto questo da molto tempo, prima ancora che gli anni Cinquanta entrassero a far parte del suo bagaglio culturale: già da tempo si era reso conto che l’America non era Utopia, e, cosa più importante, si era già scontrato con essa. Per Dick pensare ad una società così come Walt Whitman l’aveva immaginata era impossibile: Whitman era un poeta, Dick anche, ma la sua vocazione era la SF. Ogni pagina di Dick, oggi battezzato da molti come il poeta maledetto della fantascienza, è poesia che non lascia intravedere un solo raggio di speranza; per l’autore la società era drogata di sé stessa. P. K. Dick si riconosceva in essa, un ingranaggio ribelle introdotto suo malgrado nella propaganda della “droga sociale”, e l’unico mezzo per fuggire, almeno in via provvisoria, da tutto ciò era rappresentato dalle droghe artificiali. Whitman cantava l’uomo libero e lasciava spazio aperto alla speranza, Dick invece cantava le sofferenze di una umanità schiava senza lasciar spazio all’ottimismo.
Forse non tutti sanno che P. K. Dick, prima di diventare l’autore di culto di SF che oggi conosciamo, ha tentato indarno di far sentire la sua voce al di fuori di un contesto puramente fantascientifico: un esempio significativo di questo Dick inedito è rappresentato dal romanzo “L’uomo dai denti tutti uguali”. Scritto negli anni Sessanta, il romanzo è ambientato nell’America degli anni Cinquanta: protagonista assoluto di questa eccellente prova narrativa è una società morbosa inserita in un dissanguamento di ambientazioni rarefatte.
“L’uomo dai denti tutti uguali” non era romanzo che l’America avrebbe potuto accettare passivamente, e P. K. Dick ne era pienamente consapevole; la prima pubblicazione è postuma e risale al 1984, in Inghilterra, quando ormai Dick era già morto e le sue opere postume cominciarono ad essere oggetto di litigiosi accaparramenti: l’appetito per i diritti di pubblicazione da parte di prestigiose case editrici era maniacale.
Ne “L’uomo dai denti tutti uguali” la tecnologia e la SF sono bandite: il mondo che Dick descrive è tetro, non assume però connotazioni gotiche o ai confini della realtà. Con sapiente maestria vengono analizzati i difficili se non impossibili rapporti razziali, ma anche la violenza occulta eppur presente negli individui tutti pronti a squadernare un sorriso a trentadue denti tranne pugnalarsi poi alle spalle. Dick mette anche a nudo l’illusione che la famiglia è corrotta e che lo è ancor di più se si è formata lontano dalle nevralgie delle metropoli. I sobborghi – apparentemente rurali – sono il cuore di fermenti razzisti che finiscono poi con l’essere trasmessi sulle ali del vento ai grandi agglomerati urbani.
Con questo romanzo P. K. Dick si mostra al lettore contemporaneo in qualità di autore di mainstream. Per la prima volta si ha la possibilità di leggere splendide pagine di un autore di SF che sapeva scrivere anche al di fuori di un contesto puramente fantascientifico. “L’uomo dai denti tutti uguali” sono pagine memorabili che hanno un gusto amaro e tragicamente perfetto alla maniera di Thomas Clayton Wolfe e William Faulkner.
L’uomo dai denti tutti uguali – Philip K. Dick – traduzione di Vittorio Curtoni – Fanucci – collana Tif extra – pagine: 309 – ISBN-13 9788834723395 – € 9,90


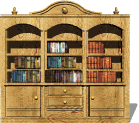






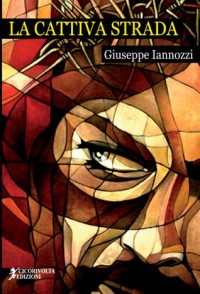


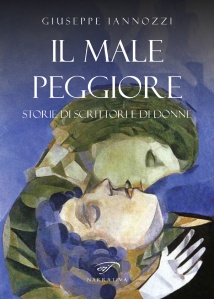
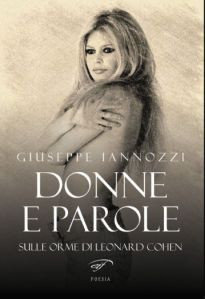

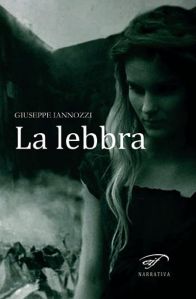

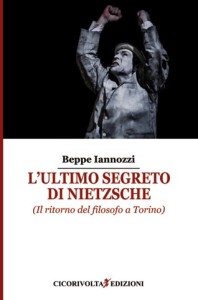
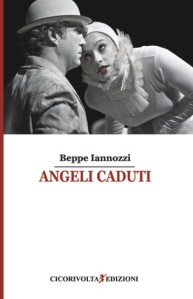





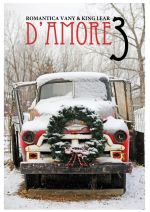

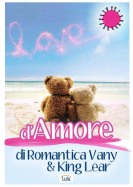
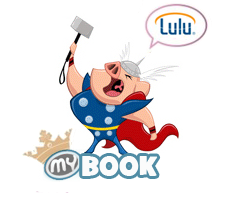











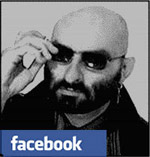















![RomanticaVany & Iannozzi Giuseppe scrivono a 4 mani biogiannozzi [& RomanticaVany]](https://iannozzigiuseppe.files.wordpress.com/2010/10/biogiannozzibanner1.jpg)


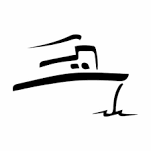






![fabio padovan [ poesia ] – taccuini Fabio Padovan](https://iannozzigiuseppe.files.wordpress.com/2010/10/fabio-padovan.jpg)



















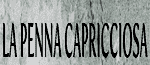








































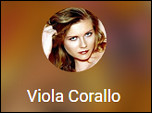
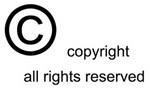




Devi effettuare l'accesso per postare un commento.